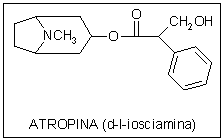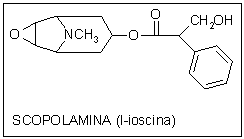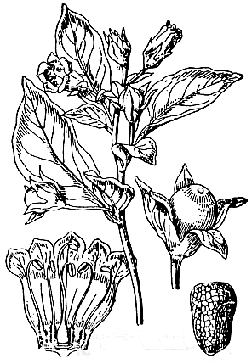Nome
scientifico
|
Atropa belladonna L. (Solanaceae) |
Nomi
popolari:
|
belladonna, solatro furioso |
Habitat:
|
Boschi di latifoglie |
Descrizione:
|
Pianta erbacea perenne pubescente, di odore sgradevole, con grossa radice e
fusto robusto, eretto, semplice alla base e ramoso in alto. Le foglie
ellittiche sono lunghe fino a 15 cm e hanno margine intero o sinuoso. I
fiori ascellari sono isolati e pendenti, viola scuri; il frutto è una bacca
nera con molti semi. |
Cenni
storici:
|
Nota già in epoca medievale per la sua pericolosità, la belladonna è una
delle pianta più usate della Materia medica. All'inizio del '700 divenne
noto l'effetto midriatico dell'estratto della pianta. I frequenti
avvelenamenti dopo ingestione dei frutti indusse i farmacologi a studi
approfonditi sulla droga. Gli effetti tossici riguardavano soprattutto il
tubo digerente e le terminazioni nervose; inoltre, secchezza delle fauci e
della secrezione oculare, mal di testa, difficoltà a leggere, stupore e
diminuzione dell'attività intellettuale. |
Curiosità:
|
Il
nome Atropa deriva dalla mitologia greca: era la Parca che tagliava
il filo della vita. L'attributo belladonna deriva invece dal
veneziano, in riferimento all'uso che si faceva del succo delle bacche,
usato come belletto e per far risplendere gli occhi. |
Parti
utilizzate in terapia:
|
Foglie |
Principi
attivi:
|
 |
Atropina (alcaloidi a nucleo tropanico) assieme a scopolamina. Bloccano i
recettori colinergici e impediscono i legami di questi con l'acetilcolina
liberata dalle terminazioni delle fibre pregangliari parasimpatiche e da
quelle postgangliari simpatiche dirette alle ghiandole sudoripare e alcuni
vasi; ciò determina tachicardia, caduta di pressione, diminuzione del tono e
motilità delle ghinadole secretive digerenti, rilasciamento dei muscoli
vescicali, aumento del tono dello sfintere vescicale (ritenzione urinaria),
nell'apparato respiratorio rilasciamento muscolare e calo selle secrezioni
bronchiali, diminuzione della secrezione salivare e dilatazione pupillare.
|
|
Usi
della pianta:
|
 |
Spasmi tonici dell'intestino |
 |
Ipersecrezione gastrica |
 |
Scialorrea |
 |
Catarri bronchiali con secrezione mucosa e nell'asma (perchè provoca
dilatazione della muscolatura e calo delle secrezioni) |
 |
Bradicardia (aumenta la frequenza cardiaca) |
|
Preparazioni:
|
 |
DOSI TERAPEUTICHE: polvere g 0,02 - 0,1 per dose; tintura FU gocce 10
per dose. |
 |
DOSI MASSIME: polvere g 0,1 per dose e g 0,4 al giorno. |
 |
OLIO PER FRIZIONI ESTERNE: belladonna estratto etereo g 10, olio di
oliva g 90. |
 |
GOCCE SEDATIVE E SPASMOLITICHE: belladonna TM g 30, valeriana TM g 30,
camomilla TM g 30, arancio TM g 10. 30 gocce al bisogno. |
|
Controindicazioni:
|
 |
Tossicità: superate le dosi terapeutiche si verificano (oltre a quelle
già descritte) accelerazione del polso, extrasistoli, fibrillazione,
arresto della peristalsi, rush cutanei, disorientamento, delirio, coma e
arresto respiratorio. |
 |
Atropina e scopolamina superano la barriera encefalica, con azione
allucinatoria (atropina) e depressivo-ipnotico (scopolamina) |
|